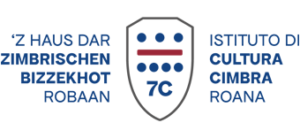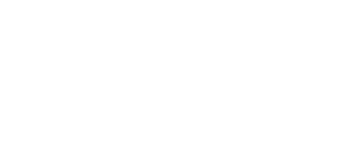Il vessillo donato dalla Serenissima ai Sette Comuni sul finire del ‘600
I cimbri sono una popolazione di lingua e costumi germanici che durante il Medioevo si stabilì sulle Prealpi veneto-trentine, ossia nel sistema di valli e montagne comprese tra i fiumi Adige e Brenta. L’origine di queste genti è una questione dibattuta da secoli: molte sono state le ipotesi fatte da diversi studiosi, spesso basate più su supposizioni o credenze che non su reali dati storici.
Le attestazioni documentali e archeologiche, infatti, sono molto scarse e non restituiscono un panorama esaustivo del territorio nei secoli tra la Tardo-Antichità e l’Alto Medioevo.
«Haec familia fugerat tempore famis ex hoc
monasterio Puronensi, in honore sancti Benedicti
constructo […], ad Veronam civitatem.»
«Questa famiglia in tempo di carestia era fuggita da questo monastero puronense, costruito in onore di San Benedetto […], verso la città di Verona.»
– È la prima attestazione della migrazione di gente di origine germanica verso l’area veneto-trentina in un testo databile attorno al 1050 e ritrovato nel monastero benedettino di Benediktbeuern (Baviera occidentale)
Le più importanti fonti in nostro possesso sono di carattere culturale. Tra queste, quella di Maggior rilevanza è la stessa lingua cimbra, una lingua di radice germanica la cui origine viene fatta risalire dai linguisti fino all’ultima fase dell’antico alto tedesco, parlato nella zona meridionale dell’odierna Germania tra VIII e XI secolo.
La migrazione dei primi “cimbri” si può quindi collocare all’interno di questa forbice temporale e spaziale.
Inoltre, dal dato linguistico si ricavano altre informazioni importanti a livello storico e demografico. Alcune forme del cimbro si distaccano dalle strutture più arcaiche e sono vicine al medio alto tedesco (parlato in Germania fino al XIV secolo); tale sovrapposizione è indice di un flusso migratorio durato alcuni secoli, durante i quali gruppi di persone oltrepassavano le Alpi in cerca di fortuna.
I primi documenti che ci danno notizia dell’Altopiano dei Sette Comuni risalgono al XIII-XIV secolo, in concomitanza con la fase di massima espansione economica delle città del nord e centro Italia. Gli scritti dell’epoca testimoniano la vitalità degli scambi tra montagna e pianura, sintomo di una presenza sociale attiva e di insediamenti sempre più stabili e organizzati: i piccoli nuclei abitati costruiscono le prime chiese, fondano le prime parrocchie e si aggregano in comunità più ampie come i Comuni e la Federazione dei Sette Comuni (primi decenni del 1300).
In quel periodo inizia però anche la progressiva diminuzione dei rapporti tra il nord Italia e il mondo tedesco dovuta ad una serie di contingenze politiche e sociali: la morte di Federico II di Svevia (1250) segna la fine del controllo imperiale sull’Italia comunale; il rallentamento dell’economia europea del 1300 e la grande epidemia di peste di metà secolo causano una profonda crisi demografica e lavorativa che mina le motivazioni alla base delle migrazioni; infine, le affermazioni della dinastia asburgica nell’Impero e di Venezia sulla terraferma veneta (tra XIV e XV secolo) rendono le Prealpi un territorio di scontro fra potenze. In questo contesto i Sette Comuni, dopo la dedizione alla Serenissima del 1405, legano il proprio destino a quello
di Venezia divenendone, nel bene e nel male, un partner commerciale e un baluardo difensivo. L’invasione napoleonica dell’Italia segna la caduta della Repubblica Veneta (1797) e, di fatto, anche della Federazione dei Sette Comuni (1807).

Dipinto che raffigura il Patto di Dedizione tra la Repubblica di Venezia e la Federazione dei Sette Comuni