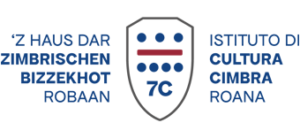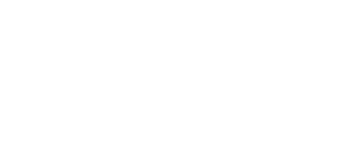L’Altopiano dei Sette Comuni è una terra ricca di tradizioni dalle radici profonde, che spesso si perdono nella storia fino all’antichità. Un tempo la vita contadina era molto legata ai cicli stagionali, ciascuno segnato da moltissimi riti e feste in una commistione di tradizioni sia cristiane che germaniche.

Uno dei roghi della “vecia” durante Schèlla Marzo
La convenzione di iniziare l’anno civile a gennaio si è consolidata in tutta Europa soltanto nel corso del XIX secolo. In precedenza, su tutto il territorio della Repubblica di Venezia, Altopiano incluso, il calendario iniziava con la fine dell’inverno e l’arrivo della primavera: il primo di marzo era il primo giorno dell’anno. Così, la festa di Schèlla Marzo (dal cimbro schèllan in mèrtzen ‘suonare marzo con i campanacci’) un tempo aveva il duplice significato di ricordare l’anno passato e di celebrare quello nuovo, di “scacciare la brutta stagione” e di “chiamare la bella”: ancora oggi gli abitanti di molti paesi dell’Altopiano, soprattutto i bambini, si ritrovano lungo le strade con campanacci, barattoli ed altri oggetti rumorosi e iniziano un fragoroso baccano che spesso culmina con un grande falò, solitamente di un’effige che personifica l’inverno detta vecia ‘vecchia’.

La Grande Rogazione di Asiago
La successiva festa primaverile è quella patronale di S. Marco a Canove, il 25 di aprile. In quell’occasione i ragazzi erano soliti donare alla propria amata un kükkle, un fischietto in terracotta a forma di volatile, ricambiato poi dalle uova, simbolo di fertilità e amore. Il rito del dono delle uova è ripreso anche durante la Grande Rogazione di Asiago, una lunga processione nata nel 1638 come una forma di ringraziamento per la fine della peste, che percorre i confini della parrocchia il giorno della vigilia dell’Ascensione. Fino a inizio ‘900 le rogazioni di ringraziamento erano un antico rito sentito e diffuso in vari paesi dell’Altopiano.
Estate e autunno erano segnati da molte feste patronali e celebrazioni legate all’economia del territorio, come le fiere in occasione delle transumanze di giugno, settembre e novembre. Mentre la fiera del 21 settembre, il giorno di San Matteo, era particolarmente sentita perché coincideva con la festa patronale di Asiago, quella di novembre era legata alla celebrazione di Tutti i Santi e alla commemorazione dei defunti. Durante la notte del primo novembre le campane venivano suonate ad ogni ora per pregare e salutare i morti che si credeva tornassero alle loro case.
L’inverno era invece caratterizzato dalle celebrazioni di Natale e Carnevale. Nei giorni del solstizio i ragazzi si recavano sulle alture per salutare il sole, mentre la sera di Natale si bruciava nel focolare un ceppo carico di significati e anche il bestiame veniva coinvolto nella festa con una pastura fino a mezzanotte. Il primo di gennaio i bambini visitavano le case del paese augurando Guuta Hant ‘buona mano’ e ricevendo in cambio monete e dolci; poco dopo, l’Epifania (Guuta gibe ‘buon regalo’) segnava la fine delle Bainèchten ‘notti di Natale’, dodici notti cariche di presagi per l’anno, e l’inizio del Vaschonkh ‘Carnevale’.
IL FOLKLORE
La tradizione popolare dei Sette Comuni è ricca di leggende e racconti fantastici, echi di un’antica religiosità germanica e nordeuropea legata al culto degli elementi naturali spesso intrecciata con il Cristianesimo, già affermato nel sud della Germania nei secoli precedenti alla partenza dei coloni cimbri.
«[…] non si è potuto svellere dall’anima dei nostri popoli parecchie superstizioni che trovano un costante alimento nella presenza di oggetti circostanti e in una rozza ma energica fantasia»
– Modesto Bonato, fine ‘800
Durante le fredde serate invernali (e non solo) gli abitanti delle contrade e dei paesi erano soliti riunirsi al tepore delle stalle per il filò: lì, mentre le donne filavano e cucivano e gli uomini sistemavano gli attrezzi, gli aneddoti della quotidianità si mescolavano a piccole e grandi storie di creature fantastiche che abitavano i Sette Comuni.

Rappresentazione del filò
L’Altopiano era un mondo di semplicità e meraviglia che si accendeva nel silenzio e nella solitudine di tante esistenze umane e dove spiriti, orchi, streghe, animali ed alberi parlanti, sanguinelli, fate, anguane, nani, elfi, diavoli ed altri esseri dimoravano interagendo con gli umani.
Personaggi, trame ed eventi di quei racconti avevano spesso la precisa funzione di restituire un insegnamento morale e di far riflettere bambini e adulti sui propri comportamenti.
L’ambientazione delle storie rispecchiava una vita trascorsa a stretto contatto con una natura fatta di monti, boschi, voragini e prati; il territorio diventava così un attore importante quanto i personaggi che lo popolavano. Ancora oggi molti luoghi mantengono nomi legati agli eventi incredibili che li avevano visti come protagonisti: la grotta delle Seeligen Baiblen, lo Stonhaus, il Tanzerloch, il Giacominerloch, il Pian della Pècca, il Buso delle Fade, …
Le anguane (ondine ammaliatrici che tipicamente dimoravano nei pressi dei corsi d’acqua), i pluutgaisten o sanguanèli (spiritelli dal colore rosso spesso autori di scherzi e malefatte), le seeligen baiblen ‘beate donnette’ (piccole fate simili a vecchiette vestite di bianco), il billar mann ‘uomo selvatico’ (rude e spesso violento), gli orchi (spesso assimilabili ai giganti della tradizione nordeuropea), i nani (piccoli esseri custodi di immensi tesori), le faaden ‘fate’ (spiriti amichevoli dai tratti cangianti) e le strìin ‘streghe’ (figure malefiche a volte sovrapposte ad anguane o a fate maligne) sono il prodotto di una memoria collettiva accumulata attraverso i secoli e custodita ancora oggi.